di Simona Pacini
Incontro Marta Zura Puntaroni nel giardino della biblioteca di via Fieravecchia, all’Università di Siena, in un pomeriggio di autunno. Il sole riscalda ancora, ma i suoi raggi non arrivano da quella parte della facoltà. “La mia vicina lo ripete sempre – dice Marta – che nel Nicchio non ci batte mai il sole”. Marta è marchigiana, di San Severino, ma ha scelto di vivere nella città del Palio, dove si è laureata in lettere. Non ha ancora compiuto trent’anni, ha i capelli tinti di verde e nel 2017 ha esordito con il romanzo Grande Era Onirica, pubblicato da minimum fax. È anche l’autrice del blog Diario di una snob.
- Due cose saltano all’occhio leggendo questo libro. Il coraggio di parlare in modo diretto, senza veli o giri di parole, di argomenti forti, scabrosi, e mi riferisco prima di tutto alla malattia mentale, alla depressione. E anche il coraggio dell’autobiografia, visto che hai chiamato la protagonista Marta, proprio come te.
“Più che di autobiografia parlerei di autofiction. Di base c’è la vita vera, il personaggio ricalca l’autore, ma non è totalmente aderente. La depressione è vera. Altre cose no.
Marco Peano ha raccontato le ultime fasi della malattia della madre nel libro L’invenzione della madre (sempre per minimum fax). Quello è autobiografico. Anche se per distanziarsi sceglie un altro nome per il protagonista.
Io, con una storia differente, ho scelto di chiamare Marta la protagonista per uno scopo “politico”, parlare apertamente della depressione. Sarebbe stato vigliacco darle un altro nome, nonostante tante altre cose non siano realmente accadute. Non volevo negare, abbandonare la depressione. Mi sarei sentita vigliacca. Per esser chiari, le cose autobiografiche sono l’infanzia e la malattia.
Pensa che l’editor della casa editrice durante la correzione del libro chiedeva di far controllare a qualcuno l’esattezza dei nomi delle medicine. Quello è così, dicevo io, puoi stare tranquillo. Ho ancora tutte le ricette.
Il libro poi attraversa altri periodi, altre realtà, anche se parte come un diario della terapia”.
- Perfettamente descritta dal titolo poi. Ma come ti è venuto in mente?
“Quello è stato il tentativo di analizzare queste terapie attraverso i sogni che procurano, dare un senso alla chimica. Poi i romanzi a volte più che da una storia nascono da una micro suggestione. A me è successo così. Quello che poi è diventato il secondo capitolo del libro era nato come post per il mio blog. Io in genere scrivo di notte. Quella volta mi era venuto un pezzo molto lungo e mi rendevo conto che così non potevo pubblicarlo. Nel 2015 sui blog non si faceva già più letteratura. Infatti ho tolto tanti pezzi che potevano essere collegati al mio nome. Stavo per buttare anche quello. Qualche settimana prima, però, al Salone del Libro di Torino avevo trovato per caso i ragazzi di 404 not found, una rivista nata a Siena che andava molto forte. Fu con loro che conobbi Alessandro Gazoia, editor di minimum fax. Mentre parliamo, lui scopre che ho un blog e mi chiede di scrivere qualcosa. Faccio resistenza. Dopo un mesetto mi trovo con questo scritto in mano. Al tempo non leggevo nemmeno autori italiani viventi. Minimum fax per me erano quelli che pubblicavano le opere minori di David Foster Wallace. In ogni caso, dopo tre settimane gli mandai il testo. Mi disse, continua, e me lo rimandò corretto. Lo insultai. Gli chiesi come si permetteva e chi si credeva di essere. All’epoca non sapevo proprio niente di questo mondo. Dopo, gli altri pezzi glieli mandavo in pdf così non poteva cambiarli”.
- Una bella fortuna per un’esordiente uscire con un editore come minimux fax.
“Minimum fax mi ha preso dalla foresta e mi ha insegnato a mangiare con forchetta e coltello. Al Salone dell’anno dopo Alessandro mi portava in giro presentandomi ai vari autori. Mi diceva, vedi loro sono scrittori normali, non insultano il loro editor se gli suggerisce di cambiare qualcosa. Ora però sono succube. Ogni cosa che dice mi va bene”.

- L’altra cosa che salta agli occhi di questo libro è la scrittura. Precisa, diretta, pulita, efficace.
“Grazie, mi fa piacere che mi dici questo. Lo scrissi in sei mesi. Anche se mi suggeriscono di non dirlo. Gazoia l’ho conosciuto nel maggio 2015 e il libro l’ho scritto fra il 2015 e il 2016. Poi è uscito nell’aprile 2017. Scrissi velocemente, ma senza consapevolezza. Continuavo a mandargli roba come se fosse una cosa normale. Ora però – mi disse lui dopo qualche mese – spediscimi i file in word che lo facciamo leggere a Nicola Lagioia (responsabile della collana Nichel, ndr). Io non mi ero resa conto che stava venendo fuori un libro. Non volevo nemmeno che venisse pubblicato. Alla fine glielo mandò lui a Nicola, senza dirmi niente, dopo essersi cambiato i pdf in word da solo.
Io lo seppi solo quando fu approvato e mi fecero firmare il contratto. Mi ritrovai in Nichel di minimum fax quasi senza accorgermene. Il contratto lo firmai senza che nessuno di loro mi avesse mai visto prima.
Sulla scrittura vorrei essere una stilista. Di base nel libro non succede niente. Anche al momento della pubblicazione feci presente come non ci fosse una vera trama. Giorgio Vasta, direttore creativo di Bookpride, una persona che stimo molto, dice che la trama la fa la scrittura”.

- Come sei arrivata, dall’immediatezza del blog, a scrivere così?
“Ho sempre scritto tanto, sempre per me stessa. Ora va di moda mandare i propri racconti alle riviste letterarie on line, dove ti controllano e ti editano. Io non l’ho mai fatto.
La mia grande scuola di scrittura è stata l’università di lettere, per tutto quello che mi ha fatto leggere, insieme a tutto quello che ho letto fin dall’infanzia e nell’adolescenza.
Una delle cose brutte della vita da scrittore è che non puoi più leggere come facevi prima. Un po’ perché ti mandano romanzi, devi leggere gli altri autori della tua casa editrice, quello che esce e che può richiamare per stile anche il tuo libro. Poi soprattutto conosci una serie di meccanismi editoriali che ti fanno apprezzare meno quello che leggi.
Ringrazio l’università che mi ha obbligato a leggere cose come Tolstoj. O Moby Dick in lingua. Aspetto la vecchiaia con impazienza (pronunciato impasiensa, alla maceratese) per potermi rimettere a leggere come prima”.
- Che cosa ti piace leggere?
“Nell’editoria indipendente trovo cose più interessanti. Nelle grandi case editrici è più facile trovare libri che ti sembrano scritti a tavolino. Io non sono mai stata una manoscrittara.
L’unica cosa che ho fatto fu quella di partecipare a un concorso di Cera di Cupra che chiedeva un racconto di quattromila battute. Si vincevano diecimila euro. Partecipai e vinsi.
Ora non ci tornerei a lettere, perché ci sono epoche che finiscono e basta. Ma è stata una cosa bella. Cinque anni passati a leggere. Ho letto molto, scritto molto. Senza alcun Super Io che mi guidasse. Ho sempre creduto nella scrittura come attività artistica, snobbando la parte artigianale. Che invece è importante. Il mio libro, quando lo rileggo, ancora mi piace.
La scrittura è come il ragazzino che corre bene, lo prendono in una squadra professionistica e deve iniziare a fare le ripetute. Il problema è che ti hanno dato l’illusione del poeta maledetto. La scrittura come un oggetto sofferto emozionale. Invece poi ti rendi conto che c’è un’artigianalità che devi portare avanti. Come le ripetute”.

- Per tutto il libro il lettore galleggia nella mente di Marta. Passa con lei da un’era onirica all’altra, ma rimane chiuso nel mondo della protagonista. Poi alla fine, quando entra in campo la famiglia, c’è il contatto con la realtà. Il terremoto di cui lei, persa dietro a sé stessa, nemmeno si era resa conto.
“Già, il terremoto. Si parla di quello dell’ottobre 2016, dopo Amatrice. Una scossa fortissima che interessò una zona enorme: Macerata, l’alta vallata del Potenza, la zona del Monte Vettore. Non ci furono morti. Anche perché quella fu l’ultima scossa di una lunga serie e ormai nessuno dormiva più in casa. Stavano in auto.
Nelle Marche dicono: te sgrulla ma nun te lama. Ti fa ballare ma non ti uccide.
Però anche ora nessun terremoto è delle Marche, anche se è stata quella la parte più colpita, la provincia di Macerata in particolare”.
- A Siena hai studiato ma poi hai deciso di viverci.
“Io amo le Marche e Siena.
Macerata fino a un po’ di tempo fa nessuno la conosceva. Poi tutto insieme non si parlava d’altro, prima il terremoto, poi Traini che ha sparato. Il terremoto ha dato una spinta enorme a tante realtà locali. Anche Lercio, per dire.
È difficile trovare marchigiani a spasso. Stanno volentieri a casa loro. Come realtà editoriali ci sono H edizione e Quod Libet a Macerata. Al Salone del libro ci incontriamo e parliamo in marchigiano. Mi chiamano San Severino, perché vengo da là.
Di Siena ho preso solo: citti, mi garba e ciaccino, che è una parola che fa uscir di testa mia sorella. No, dico anche: il mi’ babbo e la mi’ mamma, anziché mi’ padre e mi’ madre.
Poi ho preso tutti i difetti del senese, mi dicono. Per esempio, vivo in Pispini e non mi sposto mai dal Quarto di San Martino se proprio non sono costretta”.
- Dopo un libro così impegnativo hai altri progetti letterari in ballo?
“In realtà non è stato affatto estenuante, ho scritto in modo leggero. Non ne ero nemmeno cosciente. E poi ho scritto velocemente. Con l’autofiction è più facile, sei solo te a definire i limiti. Non è un libro storico per cui devi fare delle ricerche.
Dipende come sei quando inizi a scrivere, se trovi l’imbocco giusto. La scrittura è un’attività di scavo, di ritrovamento. Il libro è già dentro di te. So che può sembrare una frase un po’ fatta, ma è così. Devi fare un lavoro da archeologo.
Il nuovo romanzo sarà ambientato quasi tutto nelle Marche, nella provincia marchigiana. Più passa il tempo e più mi sento vicina a quei posti. Con il primo libro no. L’amore per Siena era totale, per la struttura sociale, per la vita di contrada.
Trovo anche diversi punti in comune fra maceratesi e senesi. Una certa indifferenza per la quotidianità, per il tempo che passa. A Siena la storia in cui vivi ogni giorno ti fa capire ciò che è importante. Nelle Marche è il rapporto, anche violento, con la natura.
Nel 2010 ero già innamorata del Palio. Andai in piazza, il Nicchio era favorito ma fu purgato. In Pantaneto camminavo in mezzo ai nicchiaioli che camminavano tristi e si sfilavano il fazzoletto. C’era un bambino che piangeva come un adulto, a bocca chiusa. La madre gli disse: ovvia dai, non fare così. Lui si girò e guardandola le disse serio: mamma, io è da quando sono nato che non ho mai vinto un Palio. Avrà avuto sette anni. Mi son venuti i brividi. Rimasi sconvolta da tanta consapevolezza del tempo. Così piccolo e già si rende conto dell’eredità che porta, del filo che lo unisce al nonno, al padre. Una cosa immensa.
Questa consapevolezza del tempo nelle Marche viene dal rapporto diretto con la terra. La crudezza della natura. La senesità mi affascina in modo violento. Il Palio è la cartina di tornasole del livello sociale dei senesi. Nelle Marche questo aspetto è rappresentato dai contadini che dopo il terremoto non abbandonano le vacche nemmeno con la neve. Tutti si stupiscono ma loro rimangono lì, con un camper, una stufetta. È questione di rispetto verso un animale che ti ha permesso di vivere. Non l’abbandoni al primo problema”.
Il sole è quasi tramontato e l’aria si va raffrescando. È arrivato il momento di salutarci.
Ci rivediamo al prossimo romanzo.
(15 dicembre 2018)





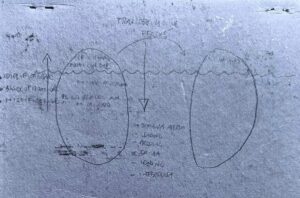



Be First to Comment