Memorie della prigionia in Giappone per denunciare la guerra: “Vivere due anni con 20 grammi di riso al giorno tra pulci e vermi”
di Annalisa Coppolaro
L’atto del mettersi a nudo, del raccontarsi e narrare la propria storia nei particolari più duri e più complessi, nelle proprie debolezze e dolori ma anche nei risvolti più intimi e nei pensieri più duri è una scelta che richiede enorme coraggio. Dacia Maraini, nata il 13 novembre 1936, l’ha fatta in quasi tutti i suoi libri, con uno stile narrativo diretto, talvolta spietato, e spesso per denunciare la crudele logica della guerra, la disumanizzazione che porta con sè nell’oppressore e nell’oppresso in modi diversi ma sempre terrificanti.

E’ arrivata a Siena il 30 gennaio, al Santa Maria della Scala, davanti a una immensa platea, per parlare del suo nuovo libro ”Vita mia, Giappone 1943, memorie di una bambina italiana in un campo di prigionia” (Rizzoli). Lo ha fatto in modo lucido e spietato, intimo e allo stesso tempo preciso e con parole che sono quelle dello stile narrativo che la caratterizza. Pochi intensi tratti di colore che non si perdono in divagazioni. Nessun indugio nella ricerca della frase lunga e complessa bensì una narrazione tipica dei grandi, che prende e travolge nella sua semplicità. E la forte emozione del ricordo d’infanzia.
Nell’intervista concessa a Offline, Dacia Maraini per prima cosa ha espresso un amore che dura da molti anni per Siena, ”esemplare per cultura e rispetto della sua antichità e per il culto dell’antica bellezza che la caratterizza. ”

La nuova fatica letteraria di Maraini, un’autrice che ha vinto tutto, dal Campiello al Premio Strega, è stata illustrata da Riccardo Castellana docente di letteratura dell’Università di Siena, con l’introduzione di Chiara Valdambrini direttore del complesso museale del Santa Maria della Scala e dalle emozionanti letture dell’attrice Paola Lambardi. Quasi novantenne ma esattamente la stessa di tanti anni fa, con la capacità di conquistare il pubblico grazie alla dialettica precisa, lucida e struggente, Maraini ha regalato ai senesi le storie drammatiche e sconvolgenti di una famiglia italiana, la sua, incarcerata per due anni di un campo di prigionia presso Kyoto dove Fosco Maraini, antropologo, e la moglie Topazia si erano trasferiti con i figli per lavoro.
Dopo il rifiuto dello studioso di giurare fedeltà alla Repubblica di Salò, la famiglia era stata imprigionata con altre 13 persone in un campo di prigionia per due terribili anni, quando la fame estrema, il caldo e il freddo, i parassiti e il sadismo delle guardie sono riusciti a ridurre la famiglia Maraini all’ombra di se stessa.
”Vivevamo con 20 grammi di riso al giorno, era terribile, ci davano il minimo per poter sopravvivere. I nostri carcerieri invece si sedevano sul muro del campo a mangiare e buttavano di sotto gli scarti, che noi bambini andavamo disperatamente a raccogliere, una testa di pesce o le puliture della frutta, li mangiavamo avidamente e loro ridevano a crepapelle”.
Dacia Maraini tiene a dire che è rimasta in contatto con il Giappone dove è andata anche lo scorso giugno, e nel libro descrive anche storie di amicizia e grande solidarietà con persone giapponesi come la figura di Keiko e altri giapponesi con cui è rimasta a lungo in contatto dopo il rientro in Italia.

La voglia di conservare la memoria di quegli anni aveva anche coinvolto la madre di Dacia, che negli anni del campo riuscì a tenere un diario della prigionia nascosto all’interno di un orso che apparteneva alla sorella Yuki, un diario che è stato poi pubblicato. Pagine di racconti terribili e momenti in cui credevano di non poter superare la prigionia, ma anche eroismo e determinazione, come il gesto del padre Fosco che davanti alle guardie e alla famiglia terrorizzata si è reciso un dito e lo ha gettato alle guardie in un rito simbolico che appartiene alla tradizione giapponese.
Dacia, che all’epoca aveva sette anni, ha vissuto con terrore e sofferenza i quasi due anni di prigionia. Nel libro scrive di aver molte volte mangiato le formiche che correvano sui muri del campo di prigionia e che, assieme gli altri prigionieri, la famiglia era riuscita spesso a catturare i serpenti che infestavano il campo per poi mangiarli.
”La cosa più brutta oltre al sadismo delle guardie e alla fame terribile erano i parassiti, le coperte infestate da pulci e pidocchi, e il nostro corpo che ne era ricoperta – racconta la scrittrice – La cattiveria delle guardie si esplicava in tanti modi come ad esempio le lettere che arrivavano a mio padre dalla sua mamma in Italia che venivano rese irraggiungibili per una settimana e poi al momento di leggerle ce le strappavano davanti agli occhi”.
Qual è stato, signora Maraini, il momento in cui ha perso la speranza, e il momento in cui l’ha recuperata
Alla fine del secondo anno eravamo talmente malridotti, talmente disperati, non sapevamo se la guerra finiva o non finiva, tant’è vero che eravamo sempre stati solidali, tutto si divideva tra i prigionieri, ma alla fine è venuto fuori una certa rabbia, la rabbia, la solidarietà tendeva a sparire, non per cattiveria ma perché eravamo troppo disperati, ma per fortuna è finita, se fosse continuata non ce l’avremmo fatta..
Poi quando abbiamo visto che le guardie, che si erano divertite a farci soffrire con grande sadismo, sono sparite lasciando il campo, abbiamo capito che era finita e lì abbiamo finalmente ritrovato la speranza.

Ho trovato commovente il ritorno a Bagheria, che conclude il libro, con descrizioni struggenti della bellezza del mare, del sole, della vita in Sicilia, è un po’ come una rinascita… Ne parlava anche nel suo libro ”Bagheria”.
Infatti, quei momenti che ho raccontato con i miei fratelli al mare, con la terra che ci ha accolto di nuovo dopo la prigionia in Giappone è proprio un simbolo del ritorno alla vita. Gioia e libertà che avevamo dimenticato. Non avevamo nemmeno in Sicilia tanto cibo, mettevamo abiti vecchi e non era sempre facile ma eravamo liberi e ricordo le corse felici nel sole, i bagni nelle onde salate, le fughe nell’unica bicicletta della famiglia come alcuni dei più bei momenti mai vissuti, dopo quei due anni terribili, cupi e disperati.
Una bella accoglienza, quella di Siena stasera. Grazie per averci scelto.
E’ un piacere, ogni volta che vengo qui sono colta da stupore e meraviglia. Del resto vedere una città così ben conservata nella sua storia e architettura è notevole, perché tante altre città medievali spesso sono state sconciate, qui c’è un grande rispetto e ogni volta mi sorprendo per la sua singolare bellezza. Inoltre, oggi c’era tanta gente che voleva ascoltare, capire, chiedere, gente interessata al mio lavoro e alle storie che racconto nei miei libri, anche giovanissimi. Una bella accoglienza davvero. ”



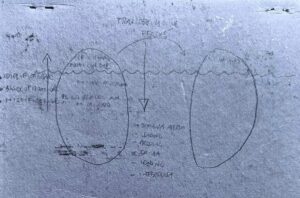



Be First to Comment