di Annarosa Bartolini
Caro Michele, di Natalia Ginzburg è stato scritto nel1973, ed è un romanzo che per metà è narrazione e per metà è epistolare.
Nella storia si scrivono e si parlano i componenti di una famiglia e i loro amici, persone che si vogliono bene, ma che non riescono a conoscersi intimamente: le loro relazioni sono fatte di occasioni perse, di rimpianti per incontri sprecati. Questo senso di incompletezza è quello che sente ognuno di loro, ma dalla lettura delle lettere e dei dialoghi, emerge anche un sentimento di appartenenza e di amore, tessuto insieme dalle memorie.
Le vicende gravitano attorno alla figura di Michele, unico maschio di una famiglia di cinque figli di genitori separati.
Nelle lettere i sentimenti e i giudizi sono ben articolati, ognuno cerca di riflettere su se stesso e sugli altri, sulle qualità delle persone e sul perché la loro presenza arricchisca la nostra vita. La madre scrive a Michele interrogandosi sulle ragioni imponderabili dell’amore del padre per lui: «Gl’importava solo di te. E il suo affetto per te sembrava rivolto non a te, ma a un’altra persona che si era inventato e che non ti rassomigliava per niente.» Descrive il suo senso di mancanza: «Non so spiegarti perché mi sento più sola da quando è morto. Forse perché avevamo in comune delle memorie. Queste memorie le avevamo solo io e lui al mondo.» Pur definendo oppressive le ore che passavano insieme, riconoscendo anche che forse insieme non sono stati mai felici, si accorge che a un certo punto della vita si amano i ricordi, anche se non sono felici.
Nel leggere questo libro, pur sapendo che Natalia Ginzburg era stata la prima traduttrice di Proust in Italia, si riescono a cogliere i legami tra Natalia Ginzburg e Marcel Proust, emersi anche in Lessico Famigliare, e si ha proprio l’impressione che la lezione della Recherche (di cui Ginzburg è stata la prima traduttrice italiana) sia penetrata a fondo nella scrittura dell’autrice torinese, non solo per il senso del tempo e del ricordare, ma anche per i riferimenti al modo di immaginare i propri pensieri proiettati negli altri, e per l’importanza che gli oggetti assumono nella vita affettiva.

Mentre i personaggi cercano di definire la propria identità e il loro posto nella famiglia e nel mondo, inseguono anche gli oggetti nelle loro case; e il ricordo degli oggetti è preciso, legato ad avvenimenti vissuti, e come gli episodi del passato è spesso avvolto da una luce che conforta.
Sono oggetti legati a momenti felici, come un cappello verde con la coda di camoscio, regali che non erano stati apprezzati, come la stufa panciuta di maiolica verde con fregi che sembravano ricami, regalata dalla madre, che Michele usa per nascondere un mitra, un tappeto sardo che non si trova più, occasione di un momento di quotidianità rimpianto, una bellissima sciarpa di vero cachemire bianca a strisce celesti che Michele vuole regalare al suo amico Osvaldo, ma che è andata smarrita e allora Osvaldo ne compra una bianca, «una sciarpetta bianca, un surrogato, ma tutti viviamo di surrogati.» Le cose hanno una loro storia e una loro identità che passa attraverso gli anni e attraverso le persone che le hanno possedute, Osvaldo a un certo punto dice che «non serve a niente conservare gli oggetti dei morti, quando sono stati maneggiati da ignoti e si è svaporata la loro identità.»
Quello dell’identità è un altro tema del romanzo, nelle lettere si parla dell’intelligenza propria e degli altri, della capacità di incidere sulla realtà, della responsabilità sull’educazione dei figli. Michele ha vissuto solo con il padre, che lo voleva tutto per sé, e i giudizi della madre riguardo a questo sono sinceramente spietati, assolutamente non assolutori: «Tuo padre certo non ti educava essendosi cacciato in testa che tu eri nato educatissimo. Così a te non ti ha educato nessuno. Sei venuto su molto balordo», e non ha paura di ammettere le sue difficoltà nei confronti delle figlie: «Nemmeno loro le ho educate o le educo perché troppo spesso mi sentivo e mi sento una persona che non mi è simpatica. Per educare un altro bisogna avere nei confronti di se stessi almeno un poco di fiducia e di simpatia.»

Questo senso di crisi, di inadeguatezza pervade quasi tutti i personaggi e li rende molto attuali. Nelle lettere il linguaggio è colloquiale, si parla anche della quotidianità, si cercano e si descrivono oggetti e persone. È un modo per sopperire la distanza dal figlio, fratello, amico che non risponde spesso, rivela poco di sé e mette gli altri semplicemente al corrente del suo matrimonio improvviso, dei trasferimenti, dei lavori e dei sogni sempre più ridimensionati. Le scelte politiche di Michele, che sembra avere contatti con gruppi di estrema sinistra, sembrano in realtà molto casuali, frutto del suo disorientamento più che di convinzioni politiche.
Pur affrontando anche una materia dolorosa, il tono piano della scrittura è vivacizzato dall’ironia sulle persone, si ironizza su tutti, sugli amici, sui parenti, e anche sui figli. Il padre definisce le sue gemelle fredde e furbe come due volpi, chiama il marito di una di loro una “rana” per aver parlato male di Cezanne. Vengono criticati quasi senza un motivo anche i nomi di battesimo: Vanessa è un nome brutto e Mara un nome da fumetto «Era meglio Maria. Con una“i” in più tutto poteva essere diverso.»
Dietro alle parole confidenziali, al tono familiare e modesto dei protagonisti o alle sparate del padre e della zia Matilde, si intuisce una solida cultura: i personaggi citano i Pensieri di Pascal, I Prolegomeni e La critica della ragion pura di Kant, un’edizione dei Fleurs du mal rilegata in marocchino rosso; la sera Osvaldo legge ad alta voce Proust per Adriana e Matilde, Mara vuole regalare a Michele un quadro di Mafai prendendolo dalla casa di un editore con cui convive per un periodo e che chiama il Pellicano.
Ma si intuisce che la loro solida posizione borghese e il loro buonsenso non riescono ad influire su quel senso di incompiutezza, sull’immaturità emotiva, sull’incapacità di condividere i propri sentimenti e la propria esistenza, come se le conversazioni fossero in realtà monologhi, come nei giochi dei bambini.
I dialoghi sono credibili, lontanissimi da comunicare visioni del mondo o credo filosofici, sono concreti, pieni di riferimenti a una realtà non esaltante ma intessuta di piccole epifanie, incontri in cui si scoprono strane vicinanze, istanti di felicità. La ricerca della felicità, la sua definizione ricorre spesso nel libro e in qualche modo mi ha ricordato “il mondo bello” cercato da Sally Rooney nel suo ultimo libro. In Dove sei mondo bello i protagonisti si scambiano email invece di lettere, anche qui alternate a brani che sembrano di un narratore abbastanza equidistante e obiettivo.
Anche nel romanzo di Rooney c’è questo senso di irrisolutezza, i personaggi non sono esemplari, ma anche loro fanno quello che possono; sono più giovani, hanno più futuro, eppure sono ugualmente consapevoli della loro inadeguatezza e della loro imperfezione. Sally Rooney ama molto Natalia Ginzburg, soprattutto Tutti i nostri ieri e all’inizio del suo libro ha riportato un piccolo brano dalle Piccole virtù:
Quando scrivo qualcosa, di solito penso che è molto importante e che io sono un grandissimo scrittore. Credo succeda a tutti. Ma c’è un angolo della mia anima dove so molto bene e sempre quello che sono, cioè un piccolo piccolo scrittore. Giuro che lo so. Ma non me ne importa molto.
Le due scrittrici hanno in comune il dono di rendere credibili le loro creature imperfette e autentiche, che non riescono mai ad esprimere la ricchezza e la profondità che nascondono. La madre di Michele parlando di Osvaldo osserva che molti lo trovano futile ed aggiunge: «Non mi sembra esatto definirlo futile, perché dalla futilità non ci si aspetta niente, e invece da lui ci si aspetta che di colpo scopra e riveli agli altri la sua ragione di esistere sulla terra. Io lo credo molto intelligente, ma sembra che la sua intelligenza la tenga custodita nel suo torace, nel suo pull-over e nel suo sorriso, trattenendosi dall’usarla per motivi che restano nascosti.»
Lo splendore delle cose ricorre in entrambi i libri. Eilen, una delle protagoniste del romanzo di Rooney descrive una notte di Dublino: “Le strade erano buie e silenziose, l’aria stranamente calda e immobile, e sul lungofiume, nei palazzi, gli uffici erano tutti illuminati, e vuoti, e sotto ogni cosa, sotto la superficie di tutto, ho iniziato a sentirla di nuovo-la prossimità, la possibilità della bellezza, come una luce soffusa che emanava da dietro il mondo visibile, illuminando ogni cosa. Non appena mi sono resa conto di quello che sentivo, ho cercato mentalmente di avvicinarmici, di toccarla, di protendermi a toccarla, ma quella sensazione si limitava a raffreddarsi o a sottrarsi, o a sgattaiolare via davanti.”
Adriana, in Caro Michele, parlando di un incontro con il marito a Villa Borghese è consapevole che i loro rapporti rimarranno una cosa vile e miserevole, però si ricorda “che il sole stava tramontando e c’erano belle nuvole sopra la città e io ero dopo tanto tempo quasi tranquilla e quasi felice”.
Osvaldo dice che coglieva lo splendore di luoghi e attimi incontrati lungo il percorso «perché io sapevo che mi sarei curvato a ricordarli. Mi ha sempre addolorato profondamente che Michele non volesse o non potesse conoscere questo splendore, e andasse avanti senza mai voltare la testa indietro. Credo però che lui senza saperlo contemplasse questo splendore dentro di me.»
Mi sembra che al di là della goffaggine e della timidezza, ci sia in queste parole qualcosa di segretamente generoso, un dono di amicizia che scorre sotto le comunicazioni del quotidiano. Cesare Garboli accosta questi personaggi a quelli di Cechov, “protagonisti di un dramma patetico non meno che ridevole, osservati con pietà ma senza nessuna commiserazione”.
La luce dell’intelligenza illumina le parole di Adriana che si accorge che la vita del figlio è diversa da come la immagina, gli dice che la sua fantasia “è sempre più sfiduciata e fiacca nell’intrecciare i suoi arabeschi sopra di te.»
Il personaggio di Angelica, sorella di Michele, è quello che sembra tenere insieme i fili che legano la famiglia; la madre si accorge di questa sua attitudine, e nonostante si renda conto della chiusura nei suoi confronti, dice che non lo fa “per debolezza di affetto, ma per il desiderio di evitarmi preoccupazioni. Strano a dirsi, Angelica ha un sentimento materno verso di me”.
Angelica si accorge delle bugie che racconta Michele, ma non lo giudica, è dispiaciuta per le sue menzogne e reticenze, ma capisce che a volte possano esserci “circostanze che ci legano alla menzogna o alla reticenza anche contro la nostra volontà”.
I personaggi sono indulgenti con le debolezze altrui, proprio perché sono consapevoli delle proprie.
A un certo punto compare Mara, una ragazza con un figlio che potrebbe essere di Michele, e che si impone nella vita degli altri perché è povera, senza mezzi, emarginata, e suscita pietà in tutti loro. Angelica le promette di occuparsi di lei, pur definendola sbandata, vagabonda e balorda. Dice alla ragazza, ma forse più a se stessa, che «ognuno di noi è sbandato e balordo in una zona di sé e qualche volta fortemente attratto dal vagabondare e dal respirare niente altro che la propria solitudine, e allora in questa zona ognuno di noi può trasferirsi per capirti.»
Questa pietà e questo riconoscersi negli altri, ci fa sentire vicini ai personaggi, come fossero nostri amici, come se in loro riconoscessimo frammenti di noi stessi; nella loro prosaicità, nelle loro debolezze, nei loro smarrimenti, nelle loro fragilità, nei loro piccoli sogni, riescono a sedurci e ad essere poetici, universali, proprio come in un racconto di Cecov.


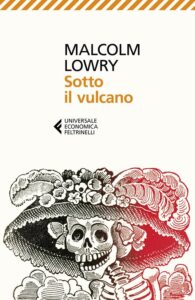




Be First to Comment