di Cristi Marci
La morte è un’opportunità oppure il riflesso di una mente troppo cosciente?
Impossibile non chiederselo e ancor più, non vedere la morte stessa quale punto definitivo di arrivo. Traguardo ultimo della nostra esistenza dove collocare quello che non si è fatto o peggio ancora quello che non si ha avuto il coraggio di accogliere. L’istinto a vivere quello che il tempo in quel dato frangente consigliava di sperimentare.
Letta in un primo momento e senza neanche un’adagiata introduzione, questa parola certamente scuote nelle fondamenta del nostro animo le certezze con le quali si è sempre stati soliti percepire, sentire e guardare al mondo.
Ma con quali occhi? Verrebbe da chiedersi. Se con quelli della superficie o viceversa attraverso quelli che a nostra insaputa albergano dentro ognuno di noi. Perché se da un lato gli occhi del mondo sono puntati su di noi, dall’altro quella lente invisibile che custodiamo nel buio dell’anima, sembra riflettere una bussola diversa e in grado peraltro di farci addentrare lungo percorsi che la coscienza comune rigetterebbe immediatamente.
Conosciuto quale detentore di un sapere lontano dai luoghi comuni il noto psicoanalista Carl Gustav Jung propone la visione della morte quale occasione quotidiana da sfruttare nel pieno delle nostre possibilità. Famoso per la sua “logica irrazionale” e non per questo meno autentica, il noto psichiatra svizzero avrebbe di che ridire sul degrado della mente attuale, così assorta e schiava di concetti predefiniti. E apparentemente priva di alternative.
In un ipotetico dialogo con l’autore, sarebbe interessante e di grande aiuto indagare quello che al giorno d’oggi il mondo circostante (e virtuale) sta operando all’interno della nostra coscienza. Se infatti quest’ultima rispecchia (o dovrebbe) un flusso di energie scevro di qualsivoglia limite, tocca purtroppo riconoscere come nel quotidiano sembri ingarbugliata in una unilateralità senza eguali.
In base alla quale tanto i comportamenti quanto le emozioni, risulterebbero incatenati ad un modello da seguire. Pena l’esclusione con annessa etichetta. Due ingredienti utili a fare dell’individualità e della libertà di espressione, due valori da debellare, da evitare e ancor più da condannare.
Se durante l’illuminismo Kant aveva definito la ragione una struttura universale e a dir poco assoluta, sembrerebbe non aver fatto i conti con quanto contenuto al suo interno. Cioè con una logica predefinita e ben collaudata che a lungo andare rischierebbe di definire l’individuo e il suo pensiero. Portando Jung a parlare di quei “classici errori illuministici” che ancora oggi rischiano di ripercuotersi sulle nostre vite e sui nostri raggi d’azione.
Proprio l’autore svizzero in una delle brevi e immense opere dal titolo Anima e Morte: Sul rinascere, aveva postulato come il periodo illuminista riflettesse proprio quel rischio di incanalare il pensiero dell’uomo in un singolo modello. E di come la ragione altro non fosse che un labirinto all’interno del quale perdere le nuove mete che la coscienza dell’anima propende invece per farci scoprire.
Su questa linea di pensiero e in linea con lo scenario contemporaneo, quelle medesime etichette comportamentali e rappresentazionali altro non farebbero, continua Jung se non “creare delle vere e proprie nevrosi”. Collocando ciò che siamo in una spazialità e una temporalità già definite e tuttavia limitanti la propria libertà, affermando sempre più come: “l’evidenza e la certezza immediata sono a rigore soltanto dei mezzi di prova per un a priori psicologico della forma di rappresentazione”.
Una buona revisione della critica alla ragion pura si prefigge pertanto il compito di rimettere in discussione ciò che apparentemente appare certo e sicuro. Facendo della conoscenza stessa un traguardo temporale, il cui raggiungimento pone la base per la morte di un concetto ormai obsoleto da sostituirsi ad una nuova coscienza.
Dimodoché le nostre capacità immaginative e rappresentative siano in grado di coltivare un nuovo posto per una realtà “extra spazio temporale”.
Secondo l’autore “l’essenza della psiche si estende in tenebre che sono molto al di là delle nostre categorie intellettuali” che anziché valorizzare il nostro potenziale espressivo rischiano di collocarci in una coscienza standardizzata.
Pertanto la morte segna la nascita di un’equivalenza senza fine, poiché se alla morte segue la rinascita lasciare andare un concetto vuol dire fare spazio a qualcosa di più grande che abita al nostro interno.
A supporto di quanto proposto dall’autore svizzero nella sua opera la coscienza dovrebbe assumere quei connotati aprioristici e atemporali che ne guidino le sue numerose direzioni. Essere senza spazio né tempo significherebbe allora non avere dei riferimenti che influenzino il pensiero e i nostri comportamenti.
Eppure nel momento in cui ci apprestiamo a dormire paradossalmente moriamo per rinascere il giorno successivo, abolendo quel flusso di pensieri che a livello onirico ci introducono ad un regno sconosciuto dove il controllo della ragione nulla può dinanzi all’imprevedibilità dei numerosi e infiniti contenuti onirici.
Perché non provare dunque questa medesima logica nel quotidiano che ciascuno di noi vive?
Le etichette che ci portiamo addosso oltre a rispecchiare dei costrutti mentali portano con sé il rischio di incanalarci in un’identità priva di trasformazioni e cambiamenti. I quali di contro consentono proprio la morte e dunque l’abbandono di un qualcosa che seppur conosciuto ha guidato il proprio cammino lungo un sentiero ormai battuto. E che nulla ha da offrire.
Morire secondo lo psichiatra svizzero significa dunque dare voce a quello che James Hillmann aveva egregiamente definito Dàimon, inteso quale predisposizione dell’anima detentrice di una propria coscienza.
Essere troppo cerebrali rischia pertanto di abolire quell’imprevedibile istino grazie al quale mille e ancor più sorprese desiderano fare capolino sia alla coscienza che nelle zone più remote del nostro animo. Dove l’autenticità ha in serbo nuove trame da farci scoprire.



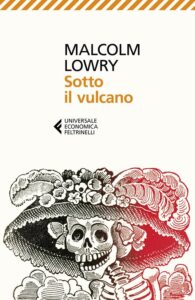



Be First to Comment