di Francesco Ricci
Quando una poesia inizia con la parola “gloria” ed esibisce, pochi versi dopo, il sintagma “per troppa luce”, è impossibile per il lettore non pensare a Dante e, in particolare, alla cantica del Paradiso. Con tutto ciò, naturalmente, che un simile rimando comporta, vale a dire la fede in Dio, una filosofia della storia di matrice agostiniana, l’idea che il male è giustificato poiché frutto del peccato. Se poi la lirica in questione rivela, sia a livello di lessico (“falbe”, “scialbato”) che di immagini (lo splendore del meriggio), importanti tangenze con l’Alcyone di D’Annunzio, a farsi strada può essere la convinzione che suddetti versi celebrino la fusione panica del poeta con la Natura e, attraverso tale processo, la divinizzazione del poeta stesso. Niente di più falso. Gloria del disteso mezzogiorno – è questa la lirica in questione, appartenente alla sezione eponima degli “Ossi di seppia” di Eugenio Montale – si pone concettualmente, infatti, agli antipodi sia del capolavoro dantesco sia del terzo libro delle “Laudi” dannunziane. Perché Dio non esiste, perché la Storia non ha né direzione né significato, perché la distanza tra il soggetto (il poeta) e l’oggetto (la realtà naturale) si conserva intatta e irriducibile, nonostante aneliti e illusioni. Di conseguenza il meriggio estivo non è più pensato (né pensabile) come l’ora nella quale il superuomo sente la propria vita farsi divina, bensì è esperito come il momento della rivelazione dello squallore, dell’aridità, dell’insensatezza dell’esistenza – di ogni esistenza – che appare in tutto assimilabile a uno scarto e a un frammento irrelato, che è dominata dalla necessità, che è segnata dal fallimento e dalla solitudine, che, in breve, è riassumibile nella formula “male di vivere”. Non a caso, la sola immagine di vita che compare nella poesia (un piccolo uccello) è subito controbilanciata e neutralizzata da un’immagine di morte (i resti di un animale in stato di decomposizione). Rimane come unica consolazione, secondo il magistero di Leopardi, il Leopardi del Sabato del villaggio, l’attesa di un tempo migliore, della pioggia che ponga fine all’arsura. Ed è in questo aspettare che per l’uomo risiede la felicità (“in attendere è gioia più compita”).
Gloria del disteso mezzogiorno
quand’ombra non rendono gli alberi,
e più e più si mostrano d’attorno
per troppa luce, le parvenze, falbe.
Il sole, in alto –, e un secco greto.
Il mio giorno non è dunque passato:
l’ora più bella è di là dal muretto
che rinchiude in un occaso scialbato.
L’arsura, in giro; un martin pescatore
volteggia s’una reliquia di vita.
La buona pioggia è di là dallo squallore,
ma in attendere è gioia più compita.
(Eugenio Montale, Gloria del disteso mezzogiorno)
(17 luglio 2019)



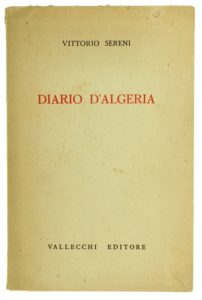
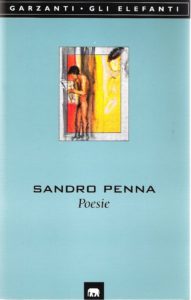


Be First to Comment