di Francesco Ricci
Il meriggio può essere un’ora del giorno molto pericolosa, come ci ricorda la sapienza degli antichi, classica e cristiana. Atteone, per avere veduto Diana nuda, viene sbranato dai propri cani, Tiresia, per lo stesso motivo, viene punito da Atena con la cecità. Ma quando il sole è a picco e i corpi non proiettano ombra, può anche accadere che il monaco sia preso da una strana indolenza, la quale lo conduce a trascurare la preghiera e l’attività di copista. Sì, quella del meriggio sa essere un’ora anche molto rischiosa. Non così, però, per Gabriele d’Annunzio, che in non poche delle poesie che compongono Alcyone, il terzo libro delle Laudi, non si stanca mai di esprimerne l’incanto voluttuoso. Quando, infatti, un afoso silenzio avvolge piante e animali e tutto pare sospeso – perfino il tempo –, al poeta può toccare in sorte di vivere un’esperienza sovrumana, l’esperienza panica, vale a dire la perdita da parte del soggetto della propria identità, che si fonde gioiosamente nella realtà naturale, al punto da partecipare della sua vita più profonda. Attraverso questa continua e reciproca metamorfosi, che antropomorfizza ciò che è naturale (il paesaggio marino) e naturalizza ciò che è umano (il poeta, a volte Ermione, la donna che gli è accanto e dietro la cui figura è riconoscibile Eleonora Duse), d’Annunzio rivela come Alcyone debba venire letto non già come una “vacanza dal superuomo”, ma come la “vacanza del superuomo”, che si concede un po’ di riposo dopo l’impegno eroico e civile che domina nei primi due libri delle Laudi, Maia ed Elettra. Solamente il superuomo, infatti, può inseguire, chiamare per nome, raggiungere e, da ultimo, possedere fisicamente non una fanciulla qualunque, ma la stessa estate personificata, espressamente richiamata già nel titolo di derivazione ovidiana (Stabat nuda Aestas). Ricorrendo a un lessico prezioso, a una fitta rete di rimandi classici, a una successione di endecasillabi musicalissimi, d’Annunzio azzera in un sol colpo l’intera tradizione lirica italiana, risalente a Petrarca, che concepiva la poesia per lo più come lo spazio dell’assenza e della sconfitta, facendone il luogo che celebra la presenza e la vittoria: per l’autore di Alcyone non c’è nessuna perdita da risarcire, ma un nuovo trionfo da celebrare.
Primamente intravidi il suo piè stretto
scorrere su per gli aghi arsi dei pini
ove estuava l’aere con grande
tremito, quasi bianca vampa effusa.
Le cicale si tacquero. Più rochi
Si fecero i ruscelli. Copiosa
la résina gemette giù pe’ fusti.
Riconobbi il colùbro dal sentore.
Nel bosco degli ulivi la raggiunsi.
Scorsi l’ombre cerulee dei rami
su la schiena falcata, e i capei fulvi
nell’argenteo pallàdio trasvolare
senza suono. Più lungi, nella stoppia,
l’allodola balzò dal solco raso,
la chiamò, la chiamò per nome in cielo.
Allora anch’io per nome la chiamai.
Tra i leandri la vidi che si volse.
Come in bronzea mèsse nel falasco
entrò, che richiudeasi strepitoso.
Più lungi, verso il lido, tra la paglia
marina il piede le si torse in fallo.
Distesa cadde tra le sabbie e l’acque.
Il ponente schiumò ne’ suoi capegli.
Immensa apparve, immensa nudità.
(Gabriele d’Annunzio, Stabat nuda Aestas)
(10 luglio 2019)

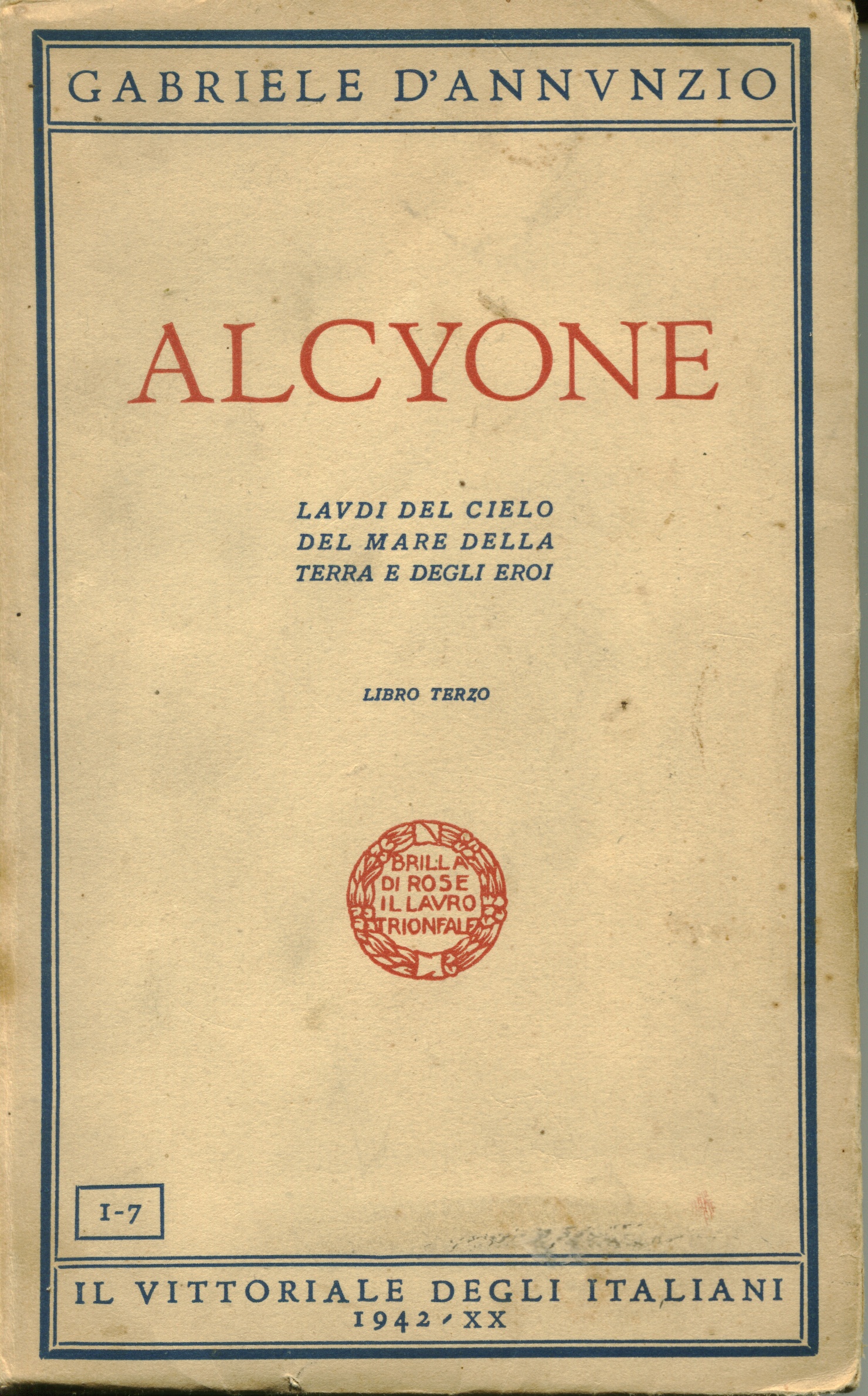

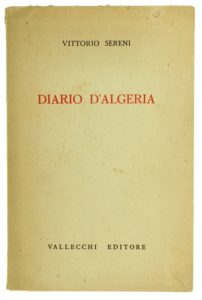
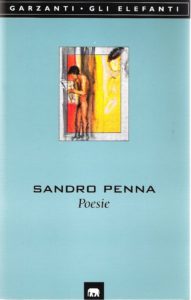


Be First to Comment