di Marco Morselli
Quando si parla di classici, spesso la prima immagine che ci passa nella testa è di un vecchio tomo polveroso o un ingombrante ammasso di pagine con le scritte piccole e una copertina non troppo accattivante. Il nome dell’autore talvolta impronunciabile, che richiama una pesantezza frutto più del pregiudizio che di altro. Ma anche laddove la maggior parte dei classici fosse così pesante e noiosa, addirittura inaffrontabile specialmente nei periodi della vita in cui gli impegni si accavallano e la mente vuole soltanto volare via, leggera, con la testa appoggiata al sedile di un autobus o sprofondata su un cuscino, lo stereotipo secondo cui certe letture “importanti” devono essere per forza lunghe e troppo difficili si frantuma in uno dei maggiori scrittori della storia della letteratura. Italo Calvino, un autore tutto nostro, che ha avuto la fortuna di farsi apprezzare anche all’estero, se ne sta lì, come uno scoglio in mezzo alle correnti di lettori confusi e sballottati qua e là tra gli scaffali di una libreria. E Il barone rampante una delle sue più grandi creature, quasi nascosto, ma sempre presente, nelle lunghe file di libri suddivisi per casa editrice. Duecento pagine appena, una storia che si sviluppa per lunghezza quasi come un racconto più che come un romanzo vero e proprio. Ma anche questo è un marchio di fabbrica calviniana, storie che si situano, un po’ borderline, tra il racconto lungo e il romanzo breve. La capacità di scrivere tutto, senza bisogno di perdersi per strada. L’abilità di creare mondi fantastici con la bellezza “icastica” di un aggettivo al posto giusto al momento giusto. Il barone rampante è probabilmente la summa dello stile di Calvino. E anche solo per questo andrebbe letto.
Per chi scrive questo articolo, Il barone rampante ha un significato affettivo particolare. È stato il primo, vero, importante libro. Letto all’età di dieci anni appena, perché sì, molti dei lavori di Calvino possono essere affrontati anche in tenera età. Sono quei romanzi che dovrebbero essere letti in ogni fase della vita, o, esagerando come il sottoscritto, anche una volta all’anno. La quintessenza del “classico”, quello che ogni volta che lo si rilegge ci permette di scoprire cose nuove, di rimettere in discussione le cose vecchie, di rimettere in discussione noi stessi. E tutto questo in duecento pagine, catapultati in un luogo fantastico, tra personaggi fantastici che recitano un copione fantastico davanti al lettore ammaliato.
Alla fine Il barone rampante nasce da un sogno, un sogno che avrebbe ispirato l’intera trilogia di cui fa parte, I nostri antenati (assieme a Il visconte dimezzato che la apre e a Il cavaliere inesistente che la chiude), una rappresentazione fantastica dell’uomo moderno. La storia di Cosimo Piovasco di Rondò, ambientata nel Settecento e parte centrale della trilogia, si concentra sull’estraniamento, il distacco dalla realtà, che è condizione fondamentale per l’intellettuale (di cui il protagonista è allegoria) affinché sia capace di osservare il mondo svincolato una volta per tutte dalle regole e dalle convenzioni sociali.
E l’occasione in cui si consuma questo distacco dalla realtà è una scena a tutti familiare: genitori e figli seduti a tavola per il pranzo, un piatto servito che uno dei figli non gradisce (nello specifico, un piatto di lumache), l’ordine perentorio del padre di consumarlo, il rifiuto insistente del figlio a obbedire. Nel trambusto che ne deriva, il giovane per protesta lascia il desco e si ritira su un albero. Un atto di rivendicazione della propria indipendenza e un atto di sfida verso la famiglia, la cui vita incardinata nella banalità della forma quotidiana lui rifiuta con tutte le sue forze. Rimarrà sugli alberi per tutto il resto della sua esistenza. Da lassù guarderà il mondo, i suoi cari, conoscerà briganti e fuggitivi, si innamorerà, studierà, vedrà i suoi cari andarsene, soffrirà e combatterà, incontrerà personaggi famosi da Napoleone al Principe Andrej (omaggio a Tolstoj?), scriverà a Voltaire e Diderot. Gli anni scorreranno, seppure in poche pagine, come pennellate di vita che si sovrappongono le une sulle altre, creando colori nuovi, mai visti, in un romanzo in cui Calvino è stato più pittore che scrittore. E il finale ci sorprenderà, lasciandoci chiudere il libro con il pensiero e la voglia di ripartire da capo, di tornare a quel piatto di lumache che il giovane Cosimo si rifiutò un giorno, coraggiosamente, di mangiare.




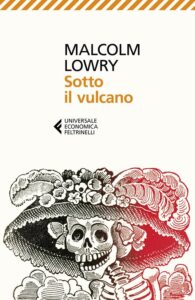



Be First to Comment